Il cielo, prima di tutto: remoto, appena 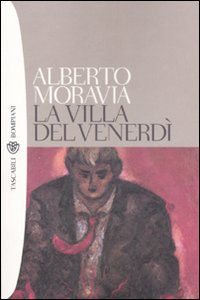 visibile lassù in alto, in fondo alla gola, come respinto indietro dalla montagna gonfia e poderosa, di un blu duro di smalto sul quale si stagliavano i picchi rosa del Gruppo di Brenta, striati di bianche falde di neve. Sotto, la massa imponente e poi serpeggiante del nevaio. Poi ancora, come una barba irsuta sotto un volto ostile, la foresta con gli abeti incalzanti in ranghi serrati all'assalto del pendio. Infine, i prati del fondovalle, di un verde luminoso, con le macchie bianche e nere delle vacche che pascolavano.
visibile lassù in alto, in fondo alla gola, come respinto indietro dalla montagna gonfia e poderosa, di un blu duro di smalto sul quale si stagliavano i picchi rosa del Gruppo di Brenta, striati di bianche falde di neve. Sotto, la massa imponente e poi serpeggiante del nevaio. Poi ancora, come una barba irsuta sotto un volto ostile, la foresta con gli abeti incalzanti in ranghi serrati all'assalto del pendio. Infine, i prati del fondovalle, di un verde luminoso, con le macchie bianche e nere delle vacche che pascolavano.
Gian Maria, disteso al sole sulla sdraio della terrazza dell'albergo, guardava questo paesaggio con occhi perplessi; non era alpinista e neppure amante della montagna: quasi stupito, si domandava che cosa era venuto a fare quaggiù, in questa valle solitaria e arcigna, invece di passare l'estate come gli altri anni in qualche affollata e cordiale località marina. La risposta alla domanda la sapeva in anticipo: per lavorare, cioè per scrivere un dramma o meglio (la distinzione per lui era importante) una tragedia; ma, pur formulandola, si rendeva conto che non era così. In realtà, sotto questa idea della tragedia da scrivere, c'era, assurda ma insistente, quella della tragedia da vivere. Gian Maria aveva diciotto anni ed era convinto di avere sino ad ora soltanto vegetato. Quello che nel suo linguaggio interiore chiamava la “vera vita”, secondo lui non l'aveva neppure sfiorato. Ora, forse perché la parola tragedia indicava insieme intensità e letteratura, la “vera vita“ non poteva essere che tragica. Di qui il pretesto della tragedia da scrivere in questo luogo severo e drammatico, forse favorevole alla tragedia da vivere.
Pensava a queste cose con sufficiente chiarezza, ma senza trarne alcuna conclusione. Poi stornò gli occhi dalla montagna e guardò alla terrazza. In fila sulle sdraio, gli ospiti dell'albergo giacevano distesi al sole, immobili e come assorti in una contemplazione «fisiologica Altri si alternavano senza troppa curiosità, oziosamente, intorno ad un cannocchiale, montato su un sostegno a tre piedi, attraverso il quale si poteva scrutare la montagna intorno. Ma in quel momento stava avvenendo una piccola scena che si ripeteva ogni giorno: un grosso corvo addomesticato, tutto nero e lucente, saltellava lungo le file delle sdraio come cercando qualche cosa. Ogni tanto si fermava, girando il capo di lato come fanno gli uccelli per guardare, quindi tendeva il collo ad afferrare col becco il laccio di una scarpa che sporgesse da una sdraio e tirava con tutta la sua forza finché il nodo non si scioglieva. Questa esibizione era seguita con divertimento e simpatia dai clienti dell'albergo che ridevano e la commentavano facetamente. Dalla sdraio immediatamente vicina a quella di Gian Maria sporgeva una scarpa di donna, un elegante scarponcino di camoscio. Il corvo si fermò, adocchiò il laccio, lo afferrò col becco e tirò. Ma il nodo non si sciolse. La donna a cui apparteneva la scarpa ritrasse il piede con violenza, esclamando: “Vattene, brutta bestiaccia!"
Gian Maria fu colpito dal tono singolare della voce, come di un'esasperazione costante e antica; e, forse, ancor più dal fatto che questa reazione, invece di riuscirgli antipatica, gli ispirasse un sentimento di simpatia. Sorpreso, guardò la donna e subito si meravigliò di non averla notata prima. Una gonfia, folta capigliatura fulva e un enorme paio di occhiali neri le riducevano il viso al naso minuscolo e alla larga bocca rossa e sensuale. Era un viso felino, ma non veniva fatto di pensare al gatto, bensì ad un animale più feroce della stessa specie, per esempio, a causa
della mascella tonda e sporgente, ad una pantera. Al contrario delle altre clienti dell’albergo, per lo più infagottate in maglioni e pantaloni sportivi, era vestita da città, con giacca e una gonna dritte di taglio maschile. Gian Maria fu anche impressionato da un particolare che gli parve significativo: ai lobi delle orecchie, al collo, ai polsi, alle dita, la donna ostentava una quantità di gioielli vistosi e massicci. Una catenella d'oro le circondava la caviglia. Aveva spalle larghe, vita ristretta e fianchi ampi, le gambe distese sulla sdraio erano magre ed eleganti. Gian Maria cercò pure di indovinare l’età e giudicò che fosse vicina ai quarant'anni.
Gian Maria era timido nella parola; forse per questo, quasi illudendosi che non si notasse, gli accadeva di essere sfrontato negli sguardi. Prese così ad osservare con insistenza la donna e intanto cercava una frase sul corvo e sulle sue prodezze che gli fornisse il pretesto per attaccare discorso. Pensò a qualche cosa come: “Che sfacciato quel corvo!”, che esprimesse solidarietà, oppure: “Perché e stata così cattiva con quel povero corvo?”, che indicasse invece disapprovazione; oppure una frase neutra come: “Come si chiama quel corvo?”; ma si accorse che, comunque la rigirasse, non sarebbe stato capace di pronunziarla a causa della timidezza. Fissava gli occhi sulla grande, enigmatica bocca rossa e carnosa e provava una sensazione di completa incapacità di parlare, accompagnata, però, dalla bizzarra idea che forse gli sarebbe stato più facile chinarsi e sfiorare con le proprie labbra quelle della sconosciuta.












